
Il Rondò della Forca, tra storie torinesi di condannati, boia, superstizioni e preghiere
 TORINO. C’è qualche autentico torinese che mi sa dire qual è il vero nome di piazza Carlina? E quello della piazza (e dintorni) che viene ancor oggi comunemente chiamata dal popolino Polo Nord? Oppure – attenti: questa è una domanda trabocchetto – qualcuno di voi conosce il vero nome del Rondò della forca?
TORINO. C’è qualche autentico torinese che mi sa dire qual è il vero nome di piazza Carlina? E quello della piazza (e dintorni) che viene ancor oggi comunemente chiamata dal popolino Polo Nord? Oppure – attenti: questa è una domanda trabocchetto – qualcuno di voi conosce il vero nome del Rondò della forca?
A chi avesse qualche dubbio, tranquilli, svelerò subito tutti gli arcani. Piazza Carlina (già chiamata piazza del Vino) non è che l’aulica piazza Carlo Emanuele II, alla confluenza tra via Accademia Albertina e via Maria Vittoria, anche se quasi nessuno a Torino la chiama così, facendosi beffe di quanto è scritto sulle targhe viarie della piazza. Il Polo Nord non è che una sineddoche, che indica una parte per il tutto: in questo modo i Torinesi doc ancora identificano la Piazza Marmolada (alla confluenza dei corsi Rosselli, Racconigi e Lione), e le vie limitrofe. Il Rondò della forca (o meglio: ël Rondó dla forca, per dirlo in piemontese) è quella rotonda (o se volete quel rond point), in cui si incrociano corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Valdocco e via Francesco Cigna. Il trabocchetto, di cui vi dicevo, sta qui. Questa rotonda non ha un’altra denominazione. Mantiene questo nome decisamente sinistro (anche se quando la si nomina non ci si fa caso) da quando – tra gli anni Trenta e Cinquanta dell’Ottocento – lì si eseguivano le pene capitali di assassini e traditori dello Stato, appendendoli ad una forca.
Prima di allora, il patibolo era stato posizionato in luoghi diversi. Si sa, il popolo ha sempre avuto una idiosincrasia naturale per catafalchi, patiboli, corde, catene e – soprattutto – per i boia (non a caso sono sorte, proprio a Torino, espressioni ed interiezioni che rievocano rapporti poco teneri con i boia e le impiccagioni, tipicamente popolari, come bòja fàuss, o ma va an sla forca!, che ancora oggi sentiamo usare dai piemontesi autentici). Forse più che altro per motivi scaramantici e di superstizione, il popolo se ne teneva (per quanto possibile) ben bene alla larga. E probabilmente, faceva rimostranze alle autorità perché le impiccagioni venissero tenute il più lontano possibile dai loro luoghi di residenza. Forse è per questo che forche e patiboli venivano spesso allestiti in luoghi diversi, e mai troppo prolungatamente nella stessa piazza o allocazione. Si iniziò così sulle rive del Po. Poi le condanne delle pene capitali vennero eseguite lungo quelle della Dora. In seguito la forca fu posizionata in piazza delle Erbe (ora piazza Palazzo di Città); e ancora, in piazza San Carlo. Anche la citata piazza Carlina – negli anni dell’occupazione francese, in cui la forca venne sostituita dalla ghigliottina – fu teatro di spettacolari esecuzioni capitali, con macabri tagli di teste a gogò.
 Ma torniamo al Rondó dla forca. La piazza sorse in un’area allora decentrata (in località Valdocco), subito dopo l’abbattimento delle mura cittadine disposto da Napoleone. Era uno slargo circolare, delimitato da alberi di alto fusto, con l’intento di rendere il contesto più “riservato”, quasi ad erigere una cortina per rendere il luogo meno accessibile agli sguardi, vista la triste destinazione che esso si ritrovò a ricoprire. Il fatto è che – se è pur vero che i Torinesi volessero tenersi a debita distanza dai boia – ogni impiccagione, annunciata dal suono lugubre delle campane a morto, costituiva pur sempre un evento che mobilitava la popolazione. Un’apparente contraddizione: assistere ad una esecuzione (oltre che una macabra evasione) era soprattutto un fatto culturale, la prova provata del riscatto sacrosanto della giustizia sul crimine. Chi si dava appuntamento al Rondò, chi si disponeva lungo il percorso che il condannato doveva coprire per giungere il luogo dell’esecuzione. Nella maggior parte dei casi, il condannato era il destinatario delle loro invettive. Talvolta però era il boia ad essere subissato d’insulti, quando il popolo non si dimostrava d’accordo con la sentenza di morte, ritenuta ingiusta.
Ma torniamo al Rondó dla forca. La piazza sorse in un’area allora decentrata (in località Valdocco), subito dopo l’abbattimento delle mura cittadine disposto da Napoleone. Era uno slargo circolare, delimitato da alberi di alto fusto, con l’intento di rendere il contesto più “riservato”, quasi ad erigere una cortina per rendere il luogo meno accessibile agli sguardi, vista la triste destinazione che esso si ritrovò a ricoprire. Il fatto è che – se è pur vero che i Torinesi volessero tenersi a debita distanza dai boia – ogni impiccagione, annunciata dal suono lugubre delle campane a morto, costituiva pur sempre un evento che mobilitava la popolazione. Un’apparente contraddizione: assistere ad una esecuzione (oltre che una macabra evasione) era soprattutto un fatto culturale, la prova provata del riscatto sacrosanto della giustizia sul crimine. Chi si dava appuntamento al Rondò, chi si disponeva lungo il percorso che il condannato doveva coprire per giungere il luogo dell’esecuzione. Nella maggior parte dei casi, il condannato era il destinatario delle loro invettive. Talvolta però era il boia ad essere subissato d’insulti, quando il popolo non si dimostrava d’accordo con la sentenza di morte, ritenuta ingiusta.
 La forca veniva installata di volta in volta. Il condannato – con le mani legate – veniva scortato dalle carceri (erano in via Corte d’Appello) al luogo di esecuzione da un corteo di soldati, dal boia e dai suoi collaboratori, e dai componenti della Confraternita della Misericordia. Le grida provenienti dalle due ali di folla venivano solo in parte attutite dai mesti canti religiosi dei membri della Confraternita, che procedevano con passo cadenzato e a testa bassa. C’era anche – a meno che il condannato ne avesse rifiutato il sostegno, ma questa era una ipotesi molto rara – un sacerdote che nel percorso forniva al condannato l’estremo supporto spirituale. Tra il 1835 e il 1852, fu Giuseppe Cafasso ad accompagnare al patibolo – fianco a fianco, con un braccio sulle spalle – ben 57 condannati a morte. Cafasso, il prete dei condannati, poi fatto santo (nel 1948 è stato dichiarato “patrone delle Carceri italiane”), sapeva sempre trovare per quei disgraziati le parole di conforto per rasserenare i loro cuori nelle ultime ore di vita, ottenendone, in extremis, il pentimento. Nel 1960, allo sbocco di corso Valdocco nel Rondò della forca, è stato posizionato un monumento dedicato a questo grande Santo piemontese.
La forca veniva installata di volta in volta. Il condannato – con le mani legate – veniva scortato dalle carceri (erano in via Corte d’Appello) al luogo di esecuzione da un corteo di soldati, dal boia e dai suoi collaboratori, e dai componenti della Confraternita della Misericordia. Le grida provenienti dalle due ali di folla venivano solo in parte attutite dai mesti canti religiosi dei membri della Confraternita, che procedevano con passo cadenzato e a testa bassa. C’era anche – a meno che il condannato ne avesse rifiutato il sostegno, ma questa era una ipotesi molto rara – un sacerdote che nel percorso forniva al condannato l’estremo supporto spirituale. Tra il 1835 e il 1852, fu Giuseppe Cafasso ad accompagnare al patibolo – fianco a fianco, con un braccio sulle spalle – ben 57 condannati a morte. Cafasso, il prete dei condannati, poi fatto santo (nel 1948 è stato dichiarato “patrone delle Carceri italiane”), sapeva sempre trovare per quei disgraziati le parole di conforto per rasserenare i loro cuori nelle ultime ore di vita, ottenendone, in extremis, il pentimento. Nel 1960, allo sbocco di corso Valdocco nel Rondò della forca, è stato posizionato un monumento dedicato a questo grande Santo piemontese.
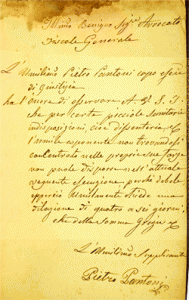 E per finire, una chicca: è il manoscritto della fotografia a lato. È un documento firmato dal torinese Pietro Pantoni, che fu uno dei più famigerati boia attivo al Rondó dla forca. Con tale istanza, l’esecutore di giustizia chiedeva ad un suo superiore una dilazione dell’esecuzione di una sentenza già passata in giudicato, perché al momento si sentiva troppo debole, a causa di una noiosa dissenteria. Ecco il testo:
E per finire, una chicca: è il manoscritto della fotografia a lato. È un documento firmato dal torinese Pietro Pantoni, che fu uno dei più famigerati boia attivo al Rondó dla forca. Con tale istanza, l’esecutore di giustizia chiedeva ad un suo superiore una dilazione dell’esecuzione di una sentenza già passata in giudicato, perché al momento si sentiva troppo debole, a causa di una noiosa dissenteria. Ecco il testo:
«Illustrissimo Avvocato Fiscale Generale , l’umilissimo Pietro Pantoni, capo esecutore di giustizia ha l’onore di osservare alla Signoria Vostra che per certe picciole sanitarie indisposizioni, cioè dissenteria, e l’umile esponente non trovandosi concentrato nelle proprie forze, non puole disporre nell’attuale seguente esecuzione, perché debole, epperciò umilmente chiede una dilazione di quattro o sei giorni. L’umilissimo supplicante: Pietro Pantoni».
La toponomastica torinese non finisce davvero mai di stupirci.





